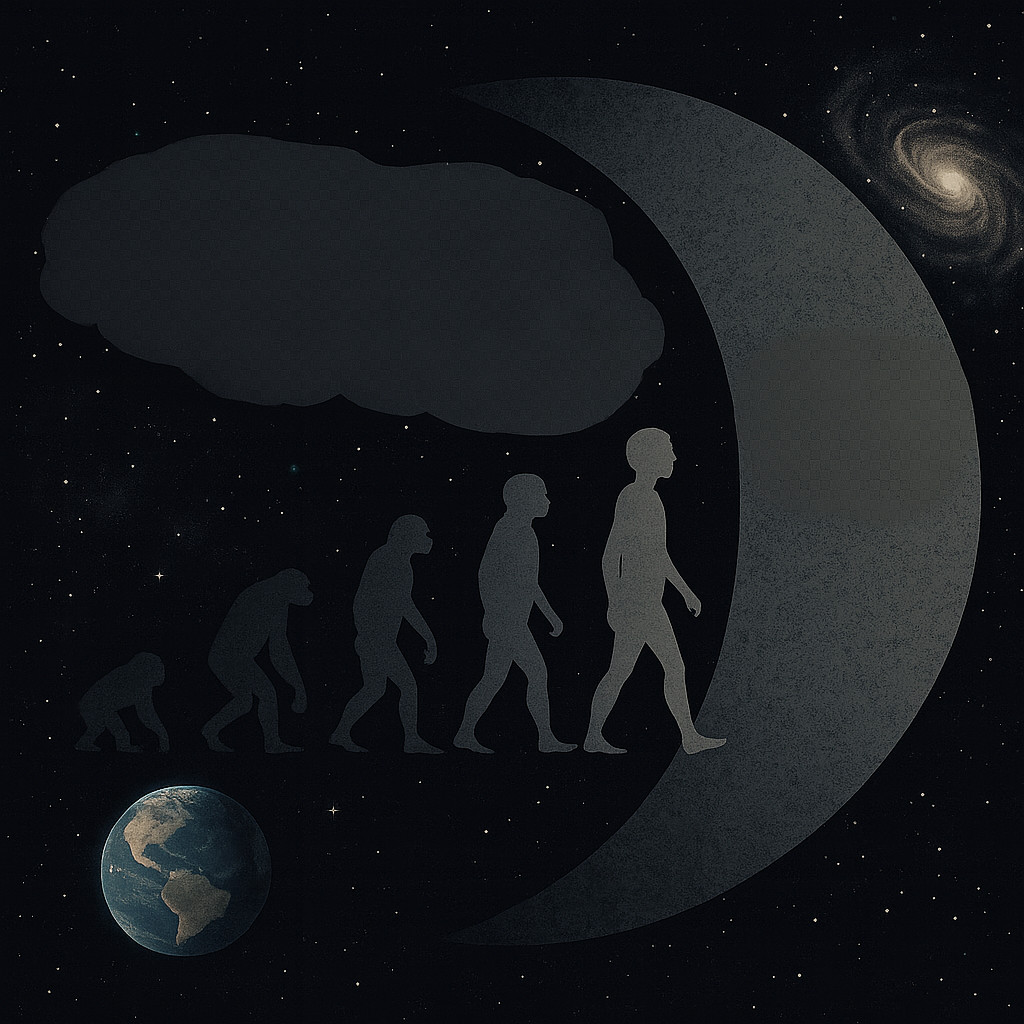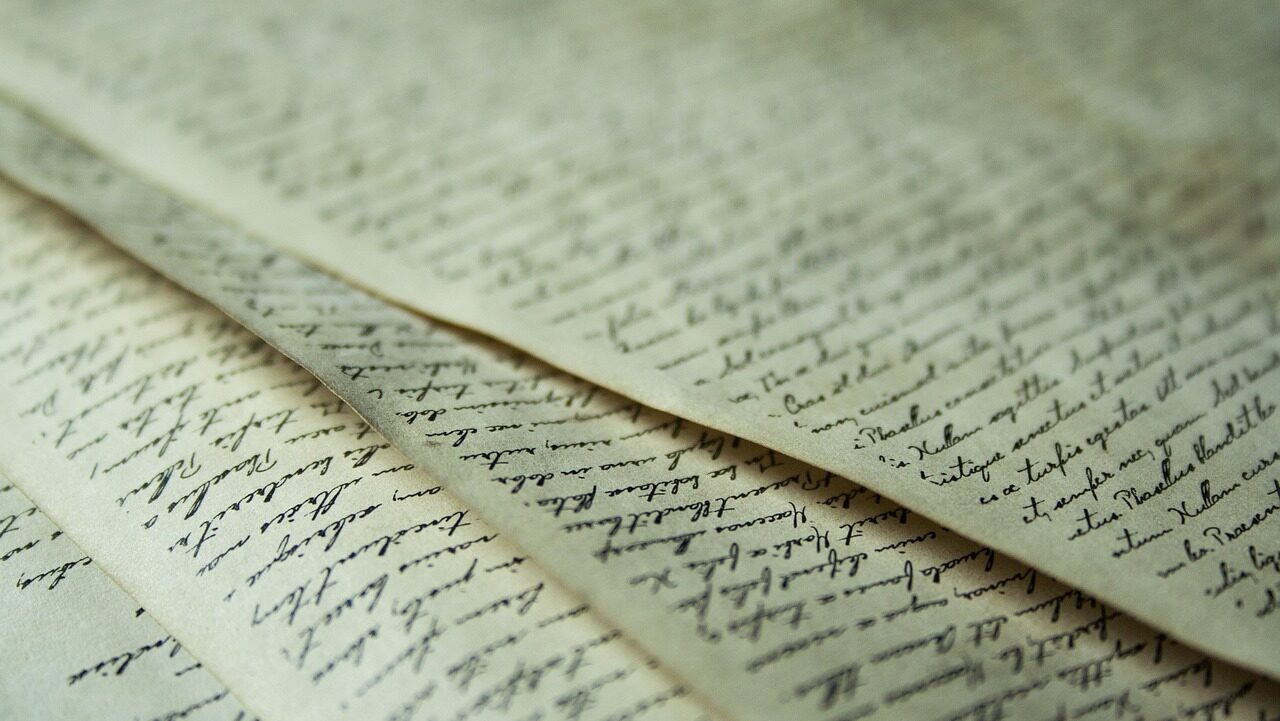Che cos’è la morte? Apparentemente, la risposta più semplice del mondo: la fine della vita. Ma allora, quando si è davvero morti? Quando si smette di respirare? Quando il cuore si arresta? O quando il cervello cessa ogni sua attività? La risposta, oggi più che mai, non è così scontata.
E le cose si complicano ulteriormente quando si osservano movimenti nel corpo di chi, secondo ogni criterio, dovrebbe essere ormai privo di vita.
Il Vangelo secondo Giovanni racconta che Lazzaro di Betania era morto da quattro giorni quando Gesù si recò al suo sepolcro, ordinò di rimuovere la pietra che lo chiudeva ed esclamò: «Lazzaro, vieni fuori». Lazzaro uscì vivo dal sepolcro, ancora avvolto nelle bende funebri, lasciando sbigottiti i presenti.
Da questo racconto evangelico prende il nome un fenomeno neurologico affascinante e inquietante: il “segno di Lazzaro”, un riflesso nervoso involontario osservabile in pazienti in stato di morte cerebrale, e talvolta perfino in cadaveri da più giorni.
Un riflesso involontario è una contrazione muscolare automatica in risposta a uno stimolo. Li abbiamo tutti sperimentati: il ginocchio che scatta quando il medico lo colpisce col martelletto, la mano che si ritrae da una superficie bollente, gli occhi che si chiudono per una luce improvvisa. Questi riflessi non sono comandati dal cervello. Avvengono perché l’impulso sensoriale raggiunge il midollo spinale, che elabora lo stimolo e risponde inviando l’impulso al muscolo. Il cervello viene informato solo dopo che il movimento è già avvenuto. Si tratta di un meccanismo primitivo, innato e stereotipato: le reazioni sono identiche in ogni individuo, progettate per rispondere rapidamente ai pericoli, guadagnando tempo prezioso.
È importante distinguere questi movimenti da altri gesti rapidi che sembrano involontari ma non lo sono: per esempio, afferrare un oggetto che sta cadendo è un atto comandato e deciso consapevolmente dal cervello, seppure molto veloce. Anche la respirazione è un atto automatico, ma non riflesso: è regolato dal tronco encefalico, che controlla l’attività dei muscoli respiratori in base ai livelli di ossigeno e anidride carbonica nel sangue.
Nel segno di Lazzaro, si osserva una flessione degli avambracci che porta le mani verso lo sterno, il collo o il mento. Dopo alcuni secondi, le braccia tornano nella posizione di partenza o si incrociano sul torace, in una posa che ricorda quella delle mummie egizie.
Questi movimenti sono osservabili in circa 20-40% dei pazienti con morte cerebrale. In casi più rari si manifestano spasmi simili all’opistotono (tipico dei malati di tetano), con testa, collo e schiena arcuati all’indietro. E in casi estremi, alcuni corpi possono persino sollevarsi in posizione seduta per qualche istante. Ma non si tratta di resurrezioni: è solo la dimostrazione di quanto il midollo spinale, pur in assenza totale di attività cerebrale, possa generare riflessi involontari sotto stimolazione.
La morte cerebrale è uno stato riconosciuto universalmente come irreversibile. Un cervello che ha cessato tutte le sue funzioni, incluso il tronco encefalico, è considerato morto.
Dopo l’accertamento della morte cerebrale, è possibile mantenere artificialmente le funzioni vitali del corpo per consentire il prelievo di organi per trapianto. Gli organi, infatti, devono essere perfusi e ossigenati fino all’espianto, altrimenti si deteriorerebbero rapidamente. Un solo donatore in morte cerebrale può salvare fino a 7-8 vite, migliorandone decine grazie alla donazione di tessuti e cellule.
Tuttavia, il segno di Lazzaro ha generato confusione e illusioni, non solo nei familiari dei pazienti ma talvolta anche tra gli operatori.
Uno dei casi più celebri riguarda Taquisha McKitty, morta cerebralmente a 27 anni nel 2017. I medici volevano interrompere la ventilazione, ma la famiglia, profondamente cattolica, interpretava i suoi numerosi riflessi come segni di vita. La vicenda si prolungò per mesi, finché la donna ebbe un arresto cardiaco.
Numerosi professionisti nel campo forense (tanatologi, necrofori, medici legali) riportano esperienze in cui i cadaveri sembrano emettere suoni, compiere spasmi o movimenti. Tuttavia, questi non sono segni di Lazzaro, che richiedono ventilazione meccanica e stimolazione spinale. Si tratta piuttosto di fenomeni post-mortem legati a scariche elettriche residue, rilascio di gas, contrazioni muscolari tardive o sviluppo del rigor mortis.
Ma ci sono stati casi di persone dichiarate morte clinicamente, che si sono poi risvegliate. Il più noto è Anthony Thomas Hoover II, dichiarato cerebralmente morto e portato in sala per la donazione degli organi. Durante il “giro d’onore” nei corridoi dell’ospedale, la sorella notò che l’uomo apriva gli occhi. Le fu detto che erano spasmi. Ma pochi minuti dopo, in sala operatoria, l’uomo si svegliò.
Casi come questo, pur rari, alimentano il dubbio: davvero la morte cerebrale è sempre irreversibile? Potremmo essere alla vigilia di scoperte capaci di rianimare un cervello così come oggi si rianima un cuore?
Il dubbio su cosa sia davvero la morte è antico quanto l’umanità. Già Platone e Aristotele si interrogavano sulla separazione dell’anima dal corpo. E nel corso dei secoli si è diffusa una delle paure più ancestrali: essere sepolti vivi.
Nel XVIII e XIX secolo, per evitare tragedie simili, inventarono le cosiddette bare di sicurezza, con campanelle legate al dito del defunto. Se si fosse risvegliato, avrebbe potuto allertare qualcuno.
La medicina, per secoli, non disponeva di strumenti affidabili per accertare la morte. Si usavano specchi sul naso per controllare il respiro o bicchieri d’acqua sul diaframma. Solo nel 1816, con l’invenzione dello stetoscopio da parte di René Laennec, si cominciò ad auscultare il cuore.
Con il tempo, l’indicatore di morte si spostò dai polmoni al cuore. Ma anche il cuore poteva fermarsi e ripartire. Solo nel XX secolo la scienza iniziò a comprendere il funzionamento del cervello.
Nel 1968, un comitato di Harvard propose una definizione operativa della morte cerebrale, oggi adottata a livello globale. Da allora, il cuore e il respiro non sono più considerati parametri univoci: è l’attività cerebrale, in particolare del tronco encefalico, a sancire la morte.
Il cervello è composto da due regioni fondamentali: la corteccia, sede delle funzioni cognitive (memoria, linguaggio, coscienza), e il tronco encefalico, che regola respirazione, coscienza e ritmi vitali. Se si danneggia la corteccia, si entra in coma. Se il tronco encefalico rimane attivo, si può respirare autonomamente e, in alcuni casi, si può anche uscire dal coma.
Lo stato vegetativo è un coma prolungato oltre 4 settimane. In alcune legislazioni, se lo stato si protrae senza miglioramenti, si può valutare la sospensione dell’alimentazione artificiale.
La morte cerebrale avviene quando cessa l’attività del tronco encefalico. In questo stato non c’è più coscienza, personalità, emozione, respiro. Il cervello inizia a decomporsi: gli enzimi liberati distruggono le cellule circostanti in un processo autodistruttivo irreversibile.
La cosiddetta morte clinica, ossia l’arresto del cuore e della respirazione, è una condizione ancora potenzialmente reversibile grazie a tecniche di rianimazione. Oggi molti la definiscono “morte apparente”. Ed è proprio in questo contesto che si collocano le esperienze di pre-morte (NDE), racconti emozionanti di chi è stato rianimato dopo l’arresto cardiaco.
Ma la morte cerebrale, certificata con protocolli rigorosi, è la vera morte.
Il segno di Lazzaro e i riflessi post-mortem ci ricordano quanto il confine tra la vita e la morte sia ancora oggetto di studio, paure e fraintendimenti. Ma al netto delle suggestioni culturali, delle leggende e dei rari casi di diagnosi errate, la scienza moderna è unanime: quando il cervello cessa definitivamente di funzionare, la vita ha lasciato il corpo.
Eppure, il fascino del mistero rimane. Forse perché, anche davanti a un corpo immobile, a un cervello che ha cessato ogni funzione, continuiamo a chiederci se la fine sia davvero definitiva. Perché anche nella morte, l’uomo cerca ostinatamente un’ultima possibilità di vita.